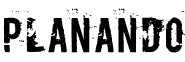LETTERATURA
Cesare Pavese: il vizio di capire
approfondimento
Quando finalmente visitai la sua casa di Santo Stefano Belbo, alcuni anni fa, non fu facile mettere in linea alcune delle cose che di lui avevo studiato già da prima degli anni dell’università, e che davo per scolpite nella pietra. Mi servì un po’ della severità sua, ma più in generale dei langaroli, per aiutarmi a trovare quanto era stato in una traccia visibile, quale in un’altra occasione importante mi era stata offerta subito, quasi sfacciatamente, alla Finca Vigia di Hemingway, dall’altra parte del mondo.
Qui, a meno di duecento chilometri da casa mia, arrivato di fronte al cancello, provai invece fastidio: quella traccia non c’era, nascosta dall’inaspettata presenza di un’osteria Slow Food (Ca' D' Gal Vesti, per la cronaca) che in altra circostanza mi avrebbe rallegrato, ricavata in una parte della struttura che, pur inconfondibile nel suo profilo per la memoria di tante fotografie, non mi sembrava poter vantare la pretenziosa denominazione di “Museo Cesare Pavese”.
La lapide apposta all’ingresso è firmata "la gente della sua terra" e il testo è tratto da "Il mestiere di vivere":
"La mia parte pubblica l'ho fatta - ciò che potevo. Ho lavorato, ho dato poesia agli uomini, ho condiviso le pene di molti".
Salite le scale che portano al piano superiore, dove in una teca di legno e vetro sono custoditi i pochi ricordi del suo lavoro e le tante fotografie, il primo elemento di sorpresa mi fu dato proprio da ciò che vedevo dalla finestra, che guarda lo stradone che porta a Canelli: se le colline delle Langhe e la lontana America sono i due estremi in cui è compresa la sua storia letteraria, se era inevitabile che a questa Pavese dovesse arrivare con l’astrazione prima e con le lettere dagli Stati Uniti dell’amico Chiuminatto poi, non mi aspettavo che fossero assenti le Langhe che avevo appena lasciato a Treiso, la mattina stessa, dove avevo camminato con i miei figli tra filari di nebbiolo e dolcetto che in quel punto non riuscivi ad immaginare neppure. Prima di trovare il Mondo Nuovo, l’astrazione aveva già il suo bel daffare già per superare la curva che inibisce lo sguardo alle case vicine.
Ero in quella casa perché da molto tempo, già allora, cercavo di integrare la conoscenza degli autori per me più importanti con gli elementi biografici che potessero darmi lo spunto in più sulle ragioni e sulle forme; e in qualche caso ho sperato, più con l’istinto che col raziocinio, di trovare il motivo di un personaggio, di un’idea o, in due casi precisi, della morte voluta.
Pavese ed Hemingway, che si sfiorarono soltanto durante la loro esistenza, avevano in comune più di quanto si pensasse, dalla disperazione sottesa a molte delle pagine scritte, anche le più apparentemente serene, ad una delle più grandi italiane del secolo (Nanda Pivano, allieva del primo e collaboratrice, letteraria ed esistenziale, del secondo come lo fu per molti altri grandi, prima e dopo la “beat generation”) che lo saluterà così: “Io gli ho voluto molto bene e non so perdonarmi di non averlo amato”.
Davide Lajolo, il langarolo che ebbe accesso al baule di Pavese e che scrisse la fortunatissima biografia "Il vizio assurdo", assegna a Pavese la stessa motivazione del suicidio che in tanti assegnarono, undici anni dopo, a Papa: l’incubo di non essere più in grado di scrivere, di "non valere più alla penna". Non sarò certo io a dire se sia stato proprio così, e ho anche i miei bravi dubbi al proposito, ché la morte dello scrittore era diventato anche un fatto politico imbarazzante per il PCI di cui Lajolo faceva parte e cui Pavese era vicino.
Dirò invece che quella mattina, davanti ai suoi appunti manoscritti, ebbi invece la percezione netta che a condannarlo fu una malattia dell’esistenza che veniva da molto lontano, che non fu lenita dal successo e da questo ne venne invece paradossalmente aggravata. Potrei accettare la tesi di Lajolo come uno degli elementi certi, e potrei anche fare tutti i pettegolezzi che lui chiese di risparmiare prima di morire, e quindi scrivere dell’amore deluso prima per la “compagna” Tina Pizzardo, dello shock iniziatico per il suicidio del suo compagno di studi Baraldi., proprio dell’amico che sapeva piacere e conquistare le donne, che si era fatto già la fidanzata e che decise di morire per amore, della passione frustrata per l’attrice americana Costance Dowling, del tentativo di darsi la morte già alcuni anni prima, delle incomprensioni e dei rancori generati dalla sua scelta di non combattere mentre i suoi amici migliori militavano e morivano nella Resistenza, della probabile impotenza, della sua difficile convivenza con la politica che pure lui stesso aveva imposto alla sua vita; potrei, certo, ma sarei sempre convinto che è ben arduo definire dove tutto questo è causa od effetto della sua sostanziale “incapacità di vivere” (espressione che Nanda Pivano usò per disegnare il profilo di un grande musicista, Chet Baker, ma che a Pavese si attaglia perfettamente) ed il vizio di capire si ferma ancora oggi, davanti all’espressione, al tempo stesso assorta e spaventata, del viso fin dagli anni del liceo, leggendo il suo diario, ascoltando il racconto di chi gli visse vicino e, in ultimo, in quella visita alla sua casa natale.
Proprio lì pensai alla terribile contraddizione del canto del cigno di Cesare (non se ne sarebbe avuto a male della mia confidenza, che negli anni della gioventù assegni a chi ti fa da tramite a scoperte importanti come mai lo saranno più nel resto della tua vita: per me, La bella estate, folgorante elaborazione di uno scivolone d’allora), costituito dal romanzo appena citato (1950) e da un “uno-due” mozzafiato, Prima che il gallo canti che comprendeva Il Carcere e La casa in collina (1949) e La luna e i falò (ancora del 1950): stiamo parlando di opere pubblicate nell’arco di tempo di poco più di un anno prima del suicidio.
Incapacità di vivere, davvero, perché quei lavori, ben diversamente dall’Hemingway che aveva lasciato Cuba, ebbero una fortuna straordinaria, perché due mesi prima del gran salto Pavese fu insignito del Premio Strega, perché la sua popolarità era all’apice tra i lettori, gli studiosi e gli editori: in mezzo a tutto questo, che avrebbe dato vita e appagamento a chiunque, lui decise di andarsene. Penso quindi che la maggiore lusinga mondana abbia acuito la sua inadeguatezza a coglierla, facendo vincere la sua dolorosa percezione di un disallineamento irrimediabile tra sé e il mondo esterno:
Tutto questo fa schifo. Non parole. Un gesto. Non scriverò più
Nessuno si era accorto, nell’afa dell’agosto torinese, che Pavese avesse preso quella terribile decisione: non gli amici della redazione de L’Unità, ai quali consigliò le foto migliori dell’archivio per un articolo su di lui, non il personale del ristorante dove si recava quasi quotidianamente, non Bona Alterocca, l’amica del quotidiano democristiano Il Popolo Nuovo che Pavese aveva cercato al giornale, e non trovò, prima di tornare per l’ultima volta all’Hotel Roma.
Uno storico, Paolo Spriano, raccontò addirittura dell'esaltazione di Pavese in quei giorni, che avrebbe potuto anche essere confusa con uno stato di felicità: con ogni probabilità, invece, lo scrittore aveva esaurito la riflessione tormentata sulla decisione da prendere, ormai già definitiva, e si stava accomiatando dall’esistenza nel migliore dei modi.
Forse le sue colline avrebbero potuto salvarlo: lì Pavese ritrovava, secondo Lajolo, la poesia e la fiducia nella vita perché "un paese vuol dire non essere solo", e se lui fosse tornato, come altri anni, all'Albergo dell'Angelo sulla piazza di Santo Stefano, a fare le sue ferie d'agosto, non si sarebbe ucciso. O forse, dico io, non se la sentì di farla finita proprio nel posto che amava tanto ma dove la sua malattia prese piglio, ché i quattro tetti che conosceva a menadito gli avevano fatto venir la voglia di mangiare la mela, per poi accorgersi di non avere i denti per quella.
Fine. Il 26 agosto del 1950 Cesare si ucciderà, lasciando dieci poesie, otto in italiano e due in inglese, dedicate a Costance, che verranno poi pubblicate con il titolo emblematico Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, e un appunto sulla pagina di frontespizio de I dialoghi:
Perdono a tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate troppi pettegolezzi”.
Dico ancora di lui, con le sue parole:
L’uomo mortale, non ha che questo d’immortale: il ricordo che porta e il ricordo che lascia”
Almeno in questo, Cesare non patirà né inadeguatezze né sconfitte.
Michele Caprini

Cesare Pavese
Bibliografia
Romanzi e racconti:
- Paesi tuoi, 1941. [romanzo]
- Prima che il gallo canti, 1948.
- La spiaggia, 1941 [romanzo breve]
- Feria d'agosto, 1946. [racconti]
- Dialoghi con Leucò, 1947. [racconti: conversazioni a due tra personaggi mitologici]
- Il compagno, 1947. [romanzo]
- La casa in collina, 1948. [romanzo]
- La bella estate, 1949.
- La luna e i falò, 1950. [romanzo]
- Notte di festa, 1953. [racconti]
- Fuoco grande 1959. [romanzo incompiuto]
- Ciau Masino, 1968.
- Lotte di giovani e altri racconti (1925-1930) 1993
Poesie:
- Lavorare stanca 1936
- La terra e la morte 1951
- Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, 1951
- Poesie del disamore e altre poesie disperse, 1962
- Poesie edite e inedite 1962.
- 8 poesie inedite e quattro lettere a un'amica (1928-1929) 1964.
- Poesie giovanili, 1923-30 1989.
Saggi e diari:
- La letteratura americana e altri saggi, 1951
- Il mestiere di vivere. Diario 1935-1950, 1952
- Interpretazione della poesia di Walt Whitman. Tesi di laurea, 1930
- Dodici giorni al mare. [Un diario inedito del 1922] 2008
- Il quaderno del confino 2010
Sceneggiature:
- Il diavolo sulle colline
- Il serpente e la colomba